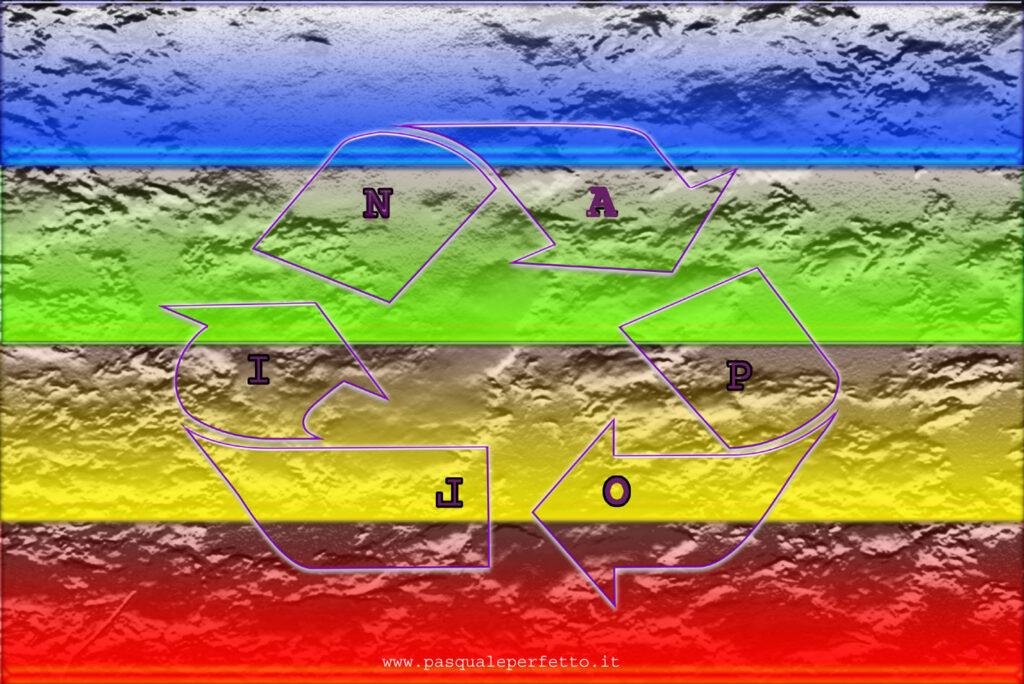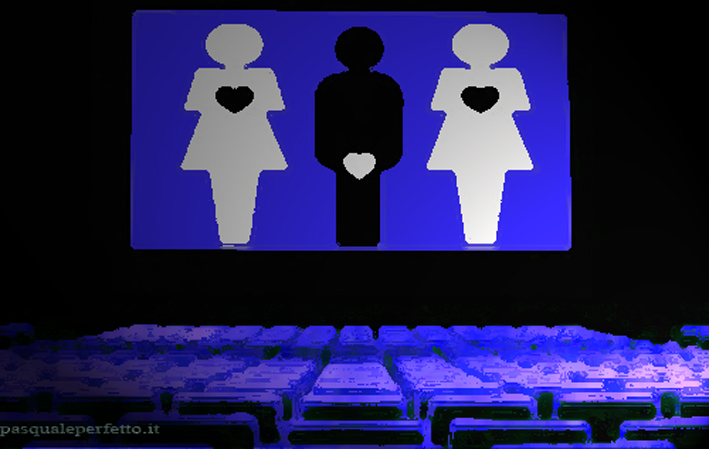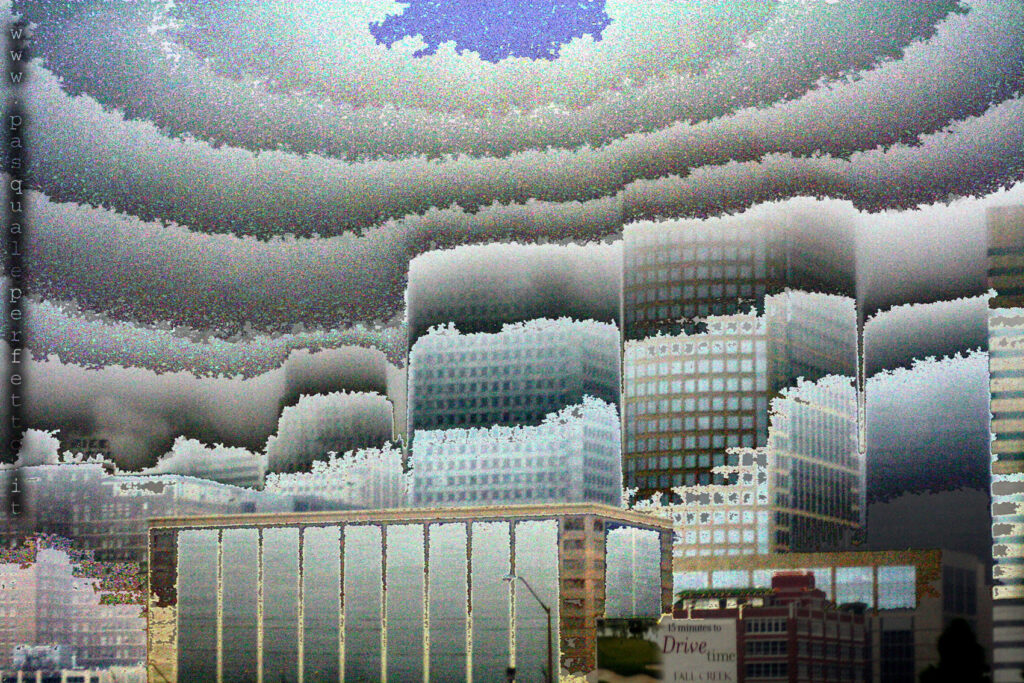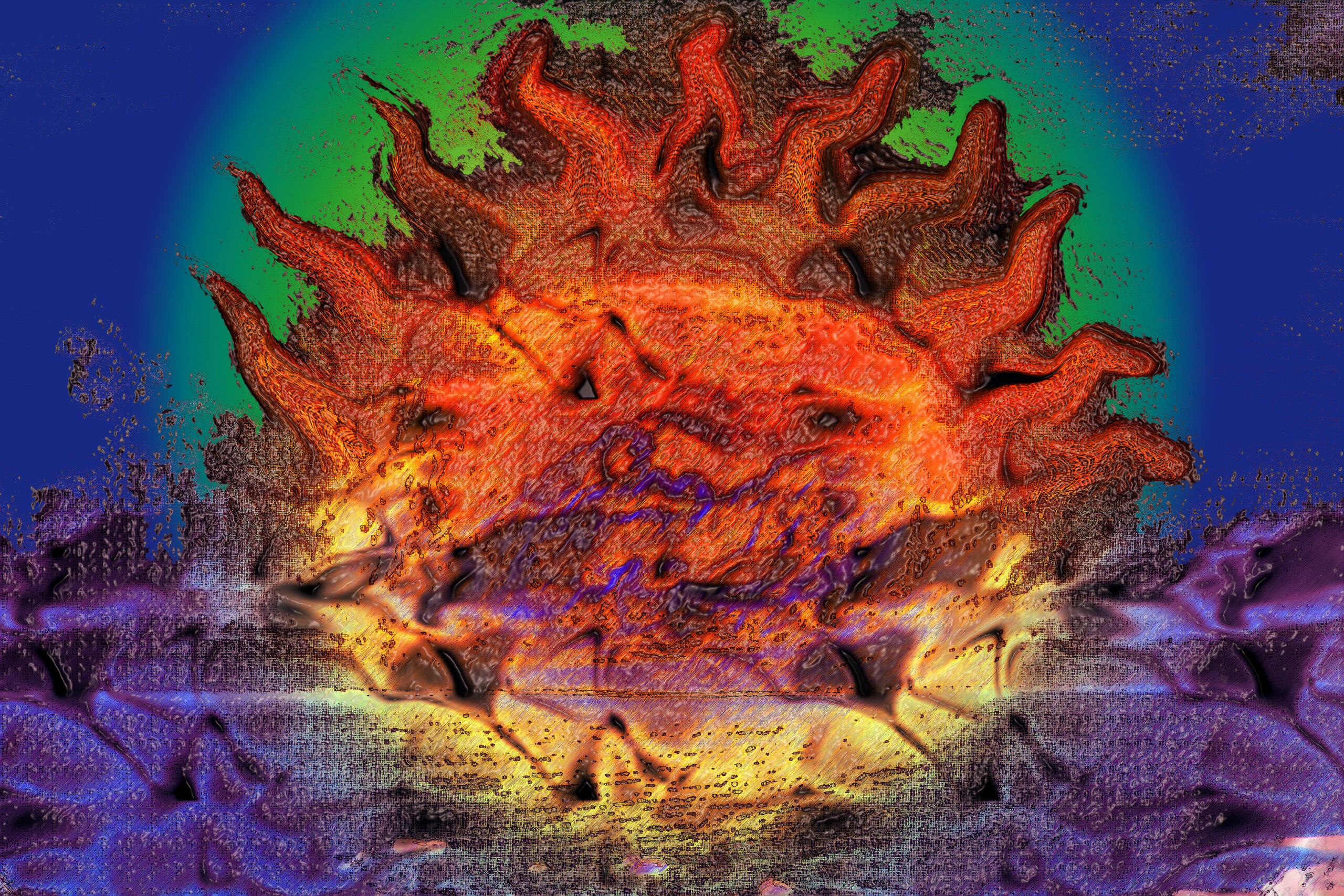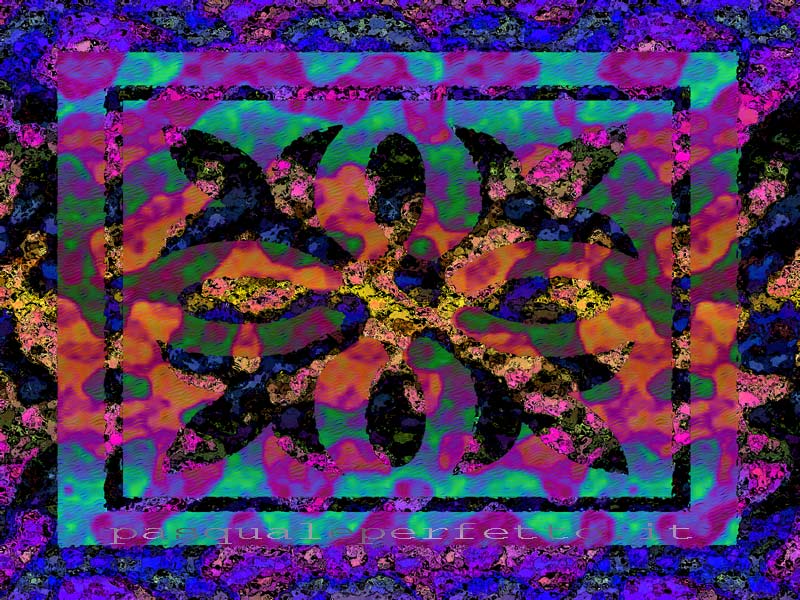E fu così che l’Uomo di Pasqua decise di andare nella patria di Ulisse.
Salpò dalla città dei fiori, nella terra dei liguri, lungo la costa italica. Ci vollero ventun leghe per arrivare, al culminar del vespro, in quel di Genova. Diede volta alle funi, pagò quarantadue pezzi d’oro e si mise in cerca di una bettola. Dopo aver saziato l’appetito, passeggiò per il vecchio scalo, in cui giocolieri, funamboli e venditrici di eros facevano da contorno. Dopo un po’ tornò a bordo, si distese nel giaciglio e si affidò a Morfeo.
Il bagliore dei primi raggi di luce lo colsero che aveva già mollato le funi da una buona lega e aveva diretto la prua lungo il litorale. Eolo non si era fatto ancora vivo e lui era costretto a navigare con il Dispositivo a ingranaggi. Dovette usarlo per tutte le ventitré leghe, fino all’arrivo nel Golfo dei Poeti, il cui centro abitato sta al nome di La Spezia.
Navigò, cosi per molte leghe fino a giungere nell’isola di Elba, dove si fermò qualche dì. Là entro in possesso di un cavallo a due ruote con cui fece il giro dell’isola, ammirando la bellezza del posto. Dopodiché puntò la prua verso riva, ma fu un errore: là fu preda della Cala della Galera che gli rubò cinquantotto pezzi d’oro e non gli permise neanche di pregare il dio Web. Da quel momento la buona stella dell’uomo di Pasqua iniziò lentamente a scolorire.
L’inizio del giorno era passato da un po’, quando, improvvisamente, il suono del Dispositivo a ingranaggi diventò incostante. Che cosa sarà? Chiese al cielo.
” Puliscimi il filtro ”, si sentì dire.
” Chi è che mi parla? ”
” Sono il Dispositivo a ingranaggi ”.
” E come si fa questa cosa? ”
” Devi sbarcare sulla terra e invocare un dio Meccanico ”.
” Grazie Dispositivo a ingranaggi, sarà fatto ”.
Si volse verso la terra etrusca e sbarcò nella Santa Marinella. Là pregò un dio Meccanico che si materializzò solo il mattino seguente. Le sembianze di questo dio non erano esattamente etrusche, tantomeno mediterranee. Poi seppe che non era un dio, ma un semidio Meccanico proveniente dalla lontana terra, tra i due fiumi, oltre il sorgere del sole. Versò quaranta pezzi d’oro e riprese il mare. Improvvisamente Eolo scatenò la sua ira, forse per gelosia o forse per rabbia, non lo seppe mai. Provò ad avvolgere la vela di prua, ma invano; e dopo alcuni tagli e qualche colpo, riuscì a liberar la fune dall’albero e la velatura cadde.
Giunto nella città di Nettuno, signore del mare e delle acque italiche, s’incamminò per le vie alla ricerca di una bottega che gli fornisse armamentario necessario per proseguire il viaggio, oltre a pane, vino e provvigioni. Trovò un desco ben fornito e fece acquisti.
La scia del naviglio si allungava lega dopo lega. Superata, indenne, la montagna di Circe (ormai la porchetta la fanno ad Ariccia), era in vista dei natii lidi. Fu all’inizio del golfo di Puteoli che il Dispositivo a ingranaggi cessò di girare. “E ora che succede?” Invocò ad alta voce l’Uomo di Pasqua. La domanda non sortì alcuna risposta. A quel punto capì che il Dispositivo a ingranaggi era privo di vita. E fu così che Il naviglio, privo del Dispositivo a ingranaggi, e in assenza di Eolo, fu preda delle onde cagionate dalle imbarcazioni degli abitanti del golfo di Puteioli e del golfo di Neapolis, che nei giorni di Venere e Saturno, dell’equinozio d’estate, si dilettano a crear marosi e frangenti, spostandosi, ad alta velocità, tra la terra ferma e le isole. Per buona sorte il naviglio derivava lontano dall’Averno: dove si trova il regno dei morti di chitemuort. Dopo aver reso omaggio agli dei, finalmente Eolo gli inviò un po’ di Maestro, così poté issare la velatura e continuare verso la sua destinazione. Giunto, dopo molte ore, nei pressi di un ricovero per navigli, fu traghettato all’interno; grato alla buona volontà di un compagno di vela. E fu lì che disse:
“Mi serve un dio di Meccanico!”
Fu grazie al canto di una sirena che prese forma un dio di Meccanico, il quale, forte nelle sue arti, fece risorgere il Dispositivo a ingranaggi. Alla fine, dopo aver chiesto come obolo quattrocentocinquanta pezzi d’oro, sentenziò:
” Stai attento Uomo di Pasqua che il Dispositivo a ingranaggi ti potrà creare altri problemi, perché è malato e ha qualche travaso ”.
” Ti ringrazio dio Meccanico e ho apprezzato la tua assistenza, ma voglio andare nella terra di Ulisse ”.
Lasciò l’ormeggio e, costeggiò il golfo delle sirene ‒ le quali erano rimaste senza voce per l’eccessiva umidità ‒, ma una riuscì a saltare a bordo: era una sirena del golfo di Neapolis, che aveva ancora un po’ di fiato nella gola e lo convinse (cantandogliene quattro) a condividere un pezzo di traversata insieme. Così l’Uomo di Pasqua, tenendosi legato all’albero saldamente, discese la costa della Lucania fino al villaggio di Maratea, in compagnia della sirena.
Dopodiché puntarono verso l’isola di Eolo, per incontrarlo e chiedergli la ragione per la quale non si faceva più vedere da qualche tempo. Ma furono vane le suppliche e le preghiere al dio: non era in casa. Forse perché l’isola stromboliava abbastanza in quel periodo, chissà.
Improvvisamente la sirena, con un tuffo elastico, lasciò il naviglio e si allontanò al richiamo della sirena genitrice; la quale aveva problemi di salute.
Così l’Uomo di Pasqua, si riempì un otre di vino, una sacca di capperi e si allontanò verso Scilla e Cariddi; sempre in mancanza di vento. Abbandonatosi alle correnti, che in quelle ore erano favorevoli, attraversò lo stretto passaggio tra la terra italica e l’Isola del Sole e sbarcò a Reggio di Calabria. Fu là che la schiena gli venne meno. La ricerca di un rimedio diventò impegnativa, ma alla fine trovò il medicamento giusto; solo che dovette inocularselo da solo.
Ormai navigava lungo la Magna Grecia. La meta era prossima. Fece una sosta a Roccella dello Ionio, ivi c’era un ricovero per navigli ben attrezzato e ben tenuto. Dopodiché si diresse verso l’antica città di Kroton, vi sostò una notte e si sfamò di pesce fino a scoppiare. Poi la bianca Leuca, nel cui abitato già conosceva una famiglia che gli offrì ospitalità, cibo, dolci e libagioni in abbondanza. Salutati gli amici, salpò verso levante. Si fermò a Fanò e poi a Merlera, e infine nell’isola dei Feaci. E lì gli dei lo abbandonarono per sempre: il Dispositivo a ingranaggi iniziò a tossicchiare senza sosta.
” Cough, cough… cough… “
” Che ti succede Dispositivo a ingranaggi? ”
” Non mi sento… cough… bene.”
” Che hai, esattamente, Dispositivo a ingranaggi? ”
” Non lo so… mi sento stanco e giro con difficoltà… cough! ”
” Adesso riposati Dispositivo a ingranaggi, pregherò un dio meccanico che venga a curarti ”.
L’Uomo di Pasqua, sbarcò in quel di Gouvia, dove c’era un buon ricovero per navigli, ma costava cinquanta pezzi d’oro al dì. In più quel posto era sottomesso al popolo teutonico che si era impossessato di quasi tutti gli attracchi Ellenici. Era preparato per quell’evenienza, sapeva a chi rivolgersi nel momento in cui il Dispositivo a ingranaggi avrebbe ceduto. S’inginocchiò e si preparò a invocare il dio Mc Giver, che in quel periodo dell’anno navigava in zona. Il dio Mc Giver gli inviò un messaggero SMS, il quale gli disse di dirigersi a sud est per quaranta leghe, esattamente nell’insediamento di Preveza dove lo stava aspettando un bravo dio Meccanico. Mentre navigava lungo l’isola dei Feaci, sentì chiamare il suo nome:
” Uomo di Pasquaaa ”
” Chi è che mi chiama? ”
” Sono io, Atena, dea della saggezza e dell’ingegno. ”
” Che cosa vuoi da me Atena ”
” Torna indietrooo, torna nella tua terraaa. Qui sei straniero in terra straniera, verrai tartassatooo ”.
” No, Atena, io devo navigare nella terra di Ulisse ”.
” Non lo fare, torna nei tuoi lidi, là conosci molti dii di Meccanici, rimanda la tua avventuraaa… ”.
” No, non voglio. Ormai è troppo tardi. Ho deciso di navigare, di conoscere altre terre, di esplorare altri mari… niente e nessuno mi farà cambiare idea! ”
” Sei un testardooo… Io ti ho avvertitooo, poi sono cazzi tuoiii ”.
Rimasto solo con i suoi tormenti , l’Uomo di Pasqua navigò quaranta leghe e al nuovo dì giunse in quel di Preveza. Inviò un messaggero SMS al dio Meccanico, il quale si materializzò il giorno dopo. Fu difficile comunicare con il dio Meccanico, ma grazie a gesti, segni e parole in lingua britanna l’Uomo di Pasqua riuscì a capire. Siccome la lingua era arcaica, per agevolare la lettura, vi sarà offerta traduzione:
” Dio Meccanico che cazzo ha il D.I.¹?”
” Il tuo D.I. è molto malato, deve essere tolto dall’alloggio e rigenerato completamente.”
” Azz… e quanto mi costa ‘sta tarantella²? ”
” Ti costa circa settemila pezzi d’oro ”
” Alla faccia… Non mi puoi fare un po’ di trattamento³? ”
” Già te l’ho fatto: nel costo ho calcolato il varo l’alaggio e la sosta a terra, che sarà almeno di quindici giorni ”.
Dopo il trascorrere di mezza luna, si palesò il dio Mc Giver, che conosceva bene le arti dell’ingegneria, della nautica, della velica e della metallica, oltre a conoscere quattro cinque idiomi diversi. Individuò alcuni difetti nel naviglio, che dovevano essere assolutamente riparati, consigliò alcune attrezzature da aggiungere e gli costruì un tetto bimini con metalli riciclati, tutto per quattromila pezzi d’oro. Passarono due lune e finalmente il naviglio era tornato come nuovo (?). L’Uomo di Pasqua, alleggerito di undicimila pezzi d’oro più quelli necessari per nutrirsi, decise che ne aveva abbastanza della terra di Ulisse, e volse la prua a ovest, verso il grande mare oceano. E mentre ripercorreva rotte conosciute, pernottò, di nuovo, in quel di Roccella dello Ionio e lì, il Dispositivo a ingranaggi ebbe un piccolo mancamento. Invocò un altro dio Meccanico che individuò subito il problema, non era niente di grave, ma quell’avvenimento fiaccò definitivamente l’Uomo di Pasqua che inviò tanti di quei muort, chitemurt e chitestramurt che il regno dell’Ade tremò tutto, la terra si scosse, le foreste bruciarono, le montagne si aprirono, i fiumi si prosciugarono i mari si ritirarono e fu così che il naviglio rimase in secca per sempre.
¹ D.I.: Dispositivo a ingranaggi – ²tarantella: lavoro, servizio – ³trattamento: sconto (ndt).